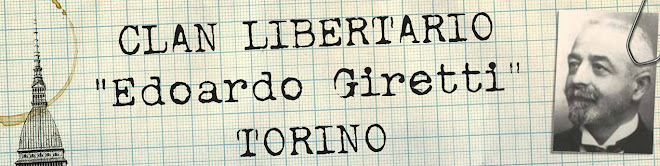Ci si vorrà mica illudere che si intenda “inadeguate” alle infinitamente più numerose rapine a mano armata, non di rado sanguinolente e finanche mortali, che esercenti delle categorie più diverse subiscono quotidianamente, senz’altra difesa, nella maggior parte dei casi, che una denuncia che il più delle volte resterà lettera morta andando a impinguare i polverosi faldoni della burocrazia di Stato? Chi conosce la “Busiarda” non ha dubbi, e infatti, pochi paragrafi sotto, l’autore dell’articolo insiste:
«Oggi il problema degli arsenali fai-da-te s’è aggravato. Il porto d’armi per difesa personale nel 2007 ha raggiunto quota 34 mila; sono state rilasciate 800 mila licenze di caccia e 178 mila per uso sportivo. Ḕ sempre più facile procurarsi armi, anche micidiali. Internet è un gigantesco mercato, spesso illegale. Poi ci sono i canali “coperti” dov’è possibile, pagando cifre modeste, acquistare armi d’ogni tipo, con pezzi provenienti dai depositi degli eserciti smobilitati dell’Est. Persino detonatori e timer per ordigni esplosivi».“La Stampa” ci regala un’altra sorpresa: la città più armata d’Italia è Torino, con un numero totale di pistole e fucili (provincia inclusa) di 60 mila, possedute per lo più da imprenditori e professionisti, seguiti da cacciatori e appassionati di tiro sportivo, e 1.400 licenze, che prefettura e questura vogliono far scendere a sotto quota 1.000. In prefettura, la linea è semplice: i richiedenti vengono “passati ai raggi X”, e se tutti i requisiti necessari non sono rispettati, la risposta è negativa. In questura, il porto d’armi viene ritirato per lo più al momento del rinnovo: «Se l’imprenditore X ha ricevuto tre anni fa minacce da ambienti malavitosi ma, nella fase attuale, non si sono più riproposte, il porto d’armi non ha più alcuna ragione d’essere».
Questo genere di provvedimenti dimostra come, in Italia, i diritti di proprietà siano concepiti in modo bizzarro, distorto e soprattutto illegittimo. Mentre infatti, come si vedrà, è consentito senza difficoltà di sorta il possesso di beni il cui utilizzo può essere pericoloso e persino mortale, la proprietà delle armi è soggetta a rigidi requisiti in assenza dei quali questo diritto è negato, per non parlare della valutazione arbitraria della “ragion d’essere” del porto d’armi.
In primo luogo, questi avversari statali del libero possesso di armi dimostrano un’impressionante cecità di fronte al fatto che un’arma, in quanto tale, è un bene come un altro, e a meno di negare l’esistenza del diritto di proprietà, la legittimità del suo possesso non è differente da quella del possesso di un orologio o di un televisore. Senza addentrarsi nelle complesse questioni filosofiche relative alla proprietà privata come diritto naturale, basterà osservare che per la maggior parte degli individui il diritto di proprietà è qualcosa di ovvio e intuitivo: se nessuno, probabilmente, pronuncerebbe un’affermazione come «il mio orologio è mio», non perché falsa ma perché clamorosamente tautologica, nessuno di noi sente il bisogno di spiegare agli altri che non possono entrare in casa sua senza il suo esplicito consenso.
Ora, se si ammette l’esistenza del diritto alla proprietà privata, non ci si può esimere dal riconoscere che chiunque può disporre delle proprie cose nel modo che preferisce, sempre che, naturalmente, le abbia ottenute con mezzi legittimi quali scambi, donazioni, acquisti, e non le utilizzi per fini aggressivi. Se un individuo ha comprato un orologio con soldi non rubati, può farne ciò che desidera, purché le sue azioni non interdicano l’analogo esercizio dei propri diritti da parte di altre persone. Vale a dire: non può, ad esempio, scagliare l’orologio dalla finestra in testa a un passante. Ha però piena libertà di determinarne l’utilizzo: portarlo al polso o lasciarlo in casa, regalarlo a un’amica o tenerlo chiuso in un cassetto, distruggerlo, metterlo nel forno o gettarlo nella vasca da bagno. Nessuno ha il diritto d’impedirgli di fare una qualsiasi di queste cose.
Ma allora, perché tutto questo non dovrebbe valere – e infatti vale - per un coltello? Le case di tutti sono piene di coltelli, di ogni forma e dimensione, alcuni dei quali molto affilati e dunque potenzialmente pericolosi, che possono essere impiegati per ferire o uccidere una persona che si trovi in casa, o lanciati a individui lontani.
Ḕ a questo punto che scaturisce la fatidica domanda, rispetto alla quale si constata una così diffusa incomprensione: che cos’è un’arma? Un’arma è un bene come un altro, non differente da un coltello o un orologio. Certo, un fucile può essere più facilmente letale rispetto a questi due oggetti (ma non rispetto, per esempio, a un’automobile). Ma, anche nel caso di un comportamento criminale o folle, non è il possesso del fucile che va sanzionato, ma l’utilizzo che se ne fa. In altri termini, non è l’arma, ma colui che preme il grilletto il responsabile del ferimento o della morte di altre persone. Un fucile o una pistola hanno una loro funzione (ferire o uccidere) così come l’hanno un frullatore, un televisore o un sasso. Noi potremmo ferire o uccidere qualcuno anche con un sasso, ma non per questo è vietato detenere sassi, e allo stesso modo, se facessimo uso di un sasso per ferire o uccidere qualcuno saremmo (giustamente!) condannati.
Come ha scritto il grande economista e pensatore libertario Murray N. Rothbard,
«Dovrebbe essere chiaro che nessun oggetto fisico è di per sé aggressivo; qualsiasi oggetto, sia esso una pistola, un coltello, o un bastone, può essere usato per aggredire, per difendersi, o per molti altri scopi che nulla hanno a che fare col crimine. Non è più logico proibire o limitare il possesso di pistole di quanto lo è proibire il possesso di coltelli, mazze, spilloni o pietre».Alcuni avanzano preoccupazioni, comprensibili e legittime, sul rischio di ferimento o addirittura di uccisione, dell’aggressore: ma chi, moralmente, si sentirebbe di considerarlo anche soltanto minimamente paragonabile al ben più concreto rischio di ferimento o di uccisione, dell’aggredito? Il punto è che il primo, aspirando a trarre il profitto dalla negazione dei diritti altrui, in qualche maniera rinuncia ai propri diritti. Vi sono situazioni in cui non è facile discernere le intenzioni dell’intruso; in queste situazioni, una pistola nelle mani dell’aggredito può fare la differenza.
Se, come è evidente, il diritto a essere proprietari di qualcosa implica che nessuno può derubarci di ciò che è nostro, altrettanto ovvio è che i ladri e i criminali esistono, ed è necessario escogitare soluzioni a difesa dei propri diritti. La soluzione che lo Stato cerca di imporci è quella di obbligarci a delegargli l’onere di difenderci dai malviventi, costringendoci ad acquistare i suoi servizi in regime di monopolio. Se è patente l’ingiustizia di questa costrizione a rivolgersi ai servizi di sicurezza offerti (imposti) da un unico fornitore, non meno importanti sono le considerazioni relative all’efficienza di questo sistema. La tesi dello Stato è che meno armi ci sono in circolazione e meno i cittadini avranno la tentazione di usarle per scopi aggressivi o per legittima difesa. «È lo Stato – sostiene Massimo Montebove, portavoce nazionale del Sap, Sindacato autonomo di polizia – che deve avere il compito di tutelare la sicurezza. La filosofia americana dell’autodifesa personale non è compatibile con la nostra cultura. E anche in America sta fallendo».
Innanzitutto, da dove salta fuori questo dogma secondo cui il “produttore” di sicurezza deve essere necessariamente lo Stato, e non esiste alcuna alternativa, precisamente quella di rifiutare la delega e assumersi in proprio la responsabilità di difendere ciò che legittimamente ci spetta? Chi ha stabilito che il proprietario, e non altri, non può essere la persona più indicata a difendere la proprietà?
L’affermazione secondo cui «la filosofia americana dell’autodifesa personale non è compatibile con la nostra cultura», poi, è addirittura tragicomica, perché induce a domandarsi immediatamente: la cultura di chi? Se il portavoce del Sap si riferisce agli italiani, allora non si capisce tutto questo allarmismo riguardo ai milioni di armi detenute legalmente nel nostro Paese, e che inducono Montebove a parlare di «emergenza grave, sempre più inquietante». Se la volontà di farsi personalmente difensori della propria incolumità e proprietà fosse davvero così estranea alla "nostra cultura", la "corsa alle armi" che tanto spaventa i sostenitori del monopolio statale della sicurezza non si verificherebbe, e non ci sarebbe motivo di preoccuparsi tanto. Invece, quelle armi sono il segnale inequivocabile che, con buona pace di Montebove, la «nostra cultura» sta cambiando, vuoi per paura (vocabolo immancabilmente sostituito da “psicosi” nel linguaggio dei giornali benpensanti), vuoi per mancanza di fiducia nei servizi di sicurezza forniti dallo Stato, vuoi per la progressiva presa di coscienza che, se certamente ogni tipo di reazione (difesa) deve essere commisurata all’azione (offesa) secondo un criterio di proporzionalità (e la valutazione della proporzionalità è precisamente il compito dei tribunali), il diritto alla proprietà privata implica, e non esclude, il corrispettivo diritto all’autodifesa.
Un’ultima osservazione su questo punto: quando il portavoce del Sap definisce estraneo alla nostra cultura il principio secondo cui la proprietà privata implica, e non esclude, il diritto all’autodifesa, ignora quanto scritto in proposito da colui che fu probabilmente il maggior giurista italiano del Novecento, Bruno Leoni: «normalmente ciascun individuo considera come legittima, perché perfettamente compatibile con quelle degli altri, la pretesa che gli altri non turbino certe situazioni in cui l’individuo si trova. La difesa personale, ad esempio, è basata sul concetto che nessuno debba offenderci ed è ammessa dalla legge; l’incolumità personale e l’integrità personale corrispondono alla pretesa che ciascuno ha di non essere assaltato e violentato. Tutte queste pretese sono normalmente considerate come compatibili, anzi lo sono perché se non lo fossero non sussisterebbero le convivenze pacifiche».
Quella tanto aborrita – da Montebove – “filosofia” è incompatibile con un’altra cultura: quella che pretende di fare dello Stato il monopolista della sicurezza, esterna e interna. Regolamentando fortemente il possesso delle armi e arrogandosi l’esclusivo diritto di perseguire i criminali, paradossalmente lo Stato ci impone la sua violenza con l’alibi di evitare le violenze di altri, ovviamente a nostre spese, con lo strumento della coercizione fiscale. A pensarci bene, è come se ogni giorno, quando usciamo di casa, lo Stato ci rapinasse di qualcosa con la scusa di proteggerci dai rapinatori. Una logica non diversa da quella del racket, con la differenza che quest’ultimo è consapevole di essere un’organizzazione criminale e di commettere una violenza.
Il portavoce del Sap, infine, sentenzia con grande sicumera che la «filosofia dell’autodifesa personale» sta fallendo anche negli Stati Uniti, ma si guarda bene dal fornire dati a dimostrazione di quanto va affermando. Secondo le più autorevoli fonti ufficiali statunitensi (che, non ce ne voglia Montebove, tendiamo a considerare più credibili, di certe affermazioni buttate “a capocchia” nel corso di un’intervista), sebbene negli Stati Uniti il numero di pistole in circolazione sia più che raddoppiato negli ultimi trent’anni, sia i suicidi sia gli omicidi (commessi con pistole o senza) sono rimasti stabili.
Non vi è alcun legame, dunque, tra questi fenomeni e non è corretto affermare che in una società armata suicidi ed omicidi tendano ad aumentare. Anzi, secondo i dati del Dipartimento di Giustizia americano, il rischio di ferimento durante un’aggressione per una donna che non opponga alcuna resistenza è 2,5 volte più grande che nel caso di resistenza armata; la resistenza senza armi è 4 volte più pericolosa che la resistenza con le armi. Per un uomo, i due rapporti assumono rispettivamente i valori di 1,4 e 1,5. Inoltre, sembra che nel 98% dei casi sia sufficiente che la vittima di un’aggressione brandisca una pistola perché il criminale desista dalle proprie intenzioni. Questo significa che nel 98% delle aggressioni contro uomini armati, il delinquente fa un buco nell’acqua e, ciò che è più importante, non vi è alcuno spargimento di sangue. Inutile chiedersi quale sia tale percentuale nel caso in cui la vittima sia disarmata.
Occorre aggiungere che, dal momento in cui le leggi e i provvedimenti che limitano il possesso di armi da fuoco entrano in vigore, i cittadini onesti si affrettano a rispettarla. Alcuni rinunceranno all’arma, altri seguiranno le procedure richieste per poterla mantenere; ma pare davvero ingenuo pensare anche solo per un attimo che i criminali si comportino nella stessa maniera. Essi, anzi, essendo – per definizione – fuorilegge, si troveranno in una situazione estremamente favorevole alla propria “attività” (nella quale dunque riceveranno un incentivo). Se infatti in una società “armata” bisogna sempre mettere in conto la possibilità di una reazione da parte dell’aggredito, in una società “disarmata” il bandito che si presenta alla vittima con una pistola in pugno avrà la strada spianata.
È del tutto evidente che la politica del disarmo forzato danneggerà soprattutto quelle categorie e quelle fasce sociali che sono più frequentemente esposte ad aggressioni (un sondaggio eseguito nel 1975 negli USA dice a che i più numerosi possessori di un’arma da fuoco a scopo puramente difensivo sono soprattutto neri, persone appartenenti a ceti dal basso reddito e anziani).
Lo aveva ben compreso, secoli fa, un altro colosso della cultura giuridica italiana, Cesare Beccaria:
«Le leggi che proibiscono di portare armi […] non disarmano che i non inclinati né determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di poter violare le leggi più sacre della umanità e le più importanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbitrarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravvenzioni, e l’esecuzione esatta delle quali toglie la libertà personale, carissima all’uomo, carissima all’illuminato legislatore, e sottopone gl’innocenti a tutte le vessazioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori, non scemano gli omicidi, ma gli accrescono, perché maggiore è la confidenza nell’assalire i disarmati che gli armati».
Giorgio Bianco